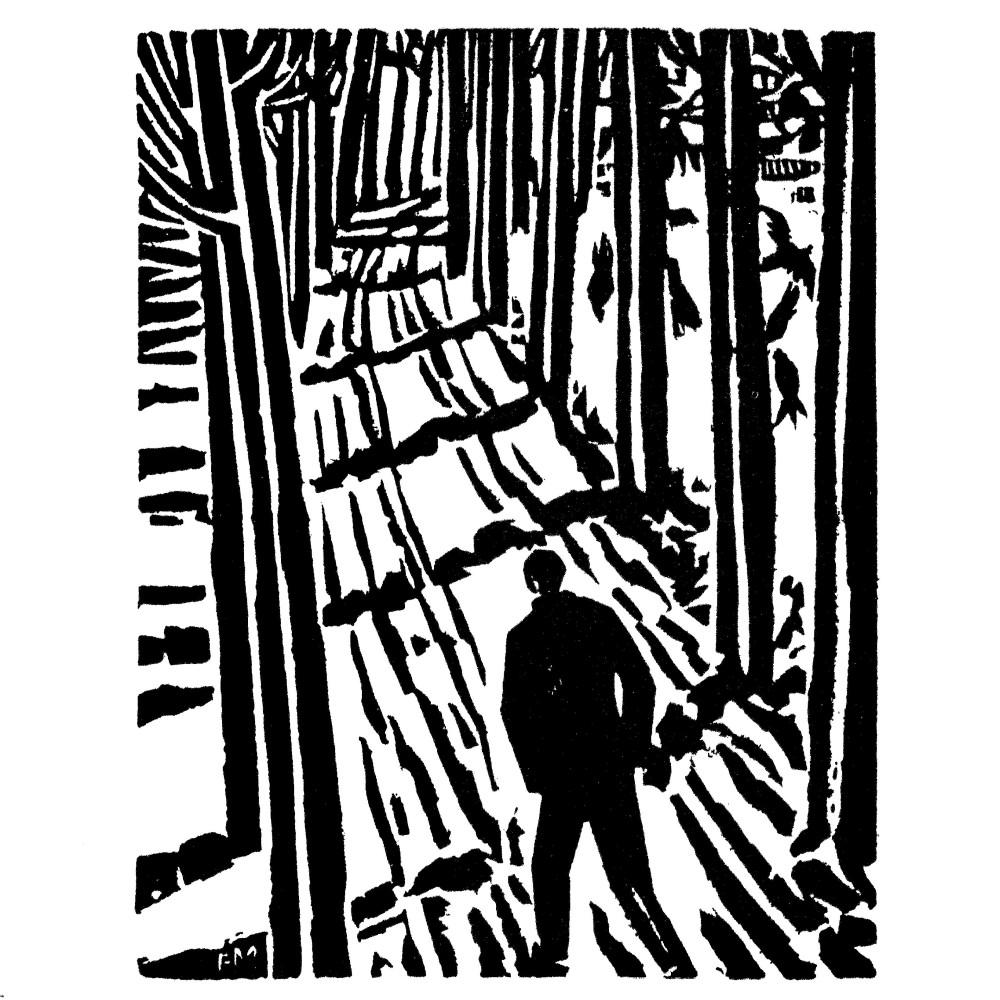Diffondiamo la postafzione all’opuscolo “La guerra come operazione di polizia internazionale” di Riccardo d’Este, curato dal nostro collettivo.
Qui l’articolo di Riccardo.
POSTFAZIONE
Sul far della sera
Perché ripubblicare, a oltre trent’anni dalla sua prima uscita, questo articolo sulla prima guerra del Golfo? Non si tratta, in fondo, di analisi datate e dal sapore un po’ rétro, oggi che il Nuovo Ordine Mondiale a trazione statunitense di cui ci parla Riccardo d’Este appare in disfacimento, incalzato da vecchi e nuovi mostri alla riscossa «multipolare», e che la categoria di Governo Mondiale è stata recuperata da paranoici e reazionari di vario pelo?
Secondo la notissima formula di Hegel, la nottola di Minerva spicca sempre il volo sul far della sera: è solo alla fine di un’epoca che la si comprende, divenendo consapevoli di un mondo che ci è passato accanto. Da questo punto di vista, i fatti degli ultimi anni illuminano queste bellissime pagine, e il tempo trascorso in mezzo, di una cruda luce retrospettiva. Se a suo tempo fece discutere la “mossa” teorica operata da Riccardo (prendere sul serio l’espressione «operazione di polizia internazionale» applicata alla prima guerra del Golfo), sono le conseguenze che ne trae questo lucidissimo compagno a esserci più utili per l’oggi: l’insufficienza di ogni spiegazione economicistica delle guerre; l’Impero capitalistico mondiale come gestore unificato dei «dislivelli» di produzione e sviluppo che esso stesso crea, e che ne permettono la riproduzione; e infine, inestricabilmente intrecciata alla «crescita esponenziale della microelettronica, della telematica, della cibernetica», la cattura della forma-Stato mondializzata sulla totalità della vita: «nonostante l’enfatica riproposizione, un po’ ovunque, di teorie “neoliberali” e “neoliberiste”, sta avvenendo esattamente l’opposto. Non è il “libero mercato” […], non è la legge del valore, bronzea o aurea, a determinare gli assetti sociali, economici e politico-istituzionali, ma, al contrario, è l’Ordine, nella forma Stato, nazionale o sovranazionale, ad imporre il mercato, a stabilire il valore, a determinare le regole dello scambio fondandosi sempre più sull’immaterialità dei beni e sullo spettacolo dei bisogni». Se Riccardo forse esagera nel proclamare – sia pure solo come tendenza – «l’autonomizzazione del capitale dai suoi stessi fondamenti», ovvero la concorrenza e la compravendita di lavoro-merce (l’attuale corsa verso la terza guerra mondiale è anche contro la concorrenza della «fabbrica del mondo» cinese, e per la riappropriazione da parte dell’Occidente del valore là prodotto), come non vedere, nel crescente furto e mercimonio dei Big Data, una immaterializzazione dei beni? Come non scorgere nei “vaccini” ad mRNA e nei vari PNRR delle gigantesche iniezioni nelle Borse di valori progettati a tavolino e alimentati a debito statale, sulla base dello «spettacolo dei bisogni» (e della paura)? E come non riconoscere, tra il campo di concentramento (divenuto nel frattempo campo di sterminio) di Gaza, e i droni che raccolgono i pompelmi a Tel Aviv, un vero e proprio concentrato dei «dislivelli» globalmente amministrati?
Queste brevi note sull’Impero, scritte nella sua fase aurorale, sono l’esatto rovesciamento – e in anticipo – dell’omonimo best seller di Hardt e Negri di circa dieci anni dopo. Il fulcro del ragionamento, che Riccardo tiene ben fermo e da cui deriva tutto il resto, è proprio l’analisi del ruolo dello Stato nel mondo contemporaneo. Laddove i due professori post-operaisti, in un micidiale miscuglio di malafede e imbecillità, scambiano il declino ideologico dello Stato nazionale con la fine dello Stato tout court, Riccardo esprime in modo raffinato un concetto semplice: nella sua epoca imperiale – quella della polizia, dei militari e della sorveglianza tecnologica a ogni angolo, e della pianificazione sempre più centralizzata in poche cabine di regia –, lo Stato non fa che estendere e intensificare il proprio intervento: «si vede, infatti, che l’autorità oppressiva dello Stato, o del Sovrastato, anziché attenuarsi, “democratizzarsi”, tende a rafforzarsi su scala planetaria. Si vede che lo Stato, l’Ordine mondiale, non è semplicemente un comitato d’affari di capitalisti associati ma tende ad esprimere la volontà, l’interesse, il senso del capitale nella sua completa interezza: ci sono, naturalmente, bande fra loro rivali, che possono arrivare anche a scontrarsi, ma tutte perseguono il medesimo fine ed attraverso lo stesso mezzo, cioè il controllo statale» (e come non pensare, qui, ai «nuovi progetti Manhattan» di tecno-armamento e tecno-sviluppo in corso un po’ ovunque, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l’Unione Europea?), laddove il fine è «“l’utopia del capitale”, il sogno cioè di eternizzarsi e sostituire la natura stessa» . Anziché essere uno «spazio liscio» che, nell’agevolare i «flussi» cibernetico-finanziari, finirebbe per liberare le «soggettività» contenute nella «moltitudine», l’assetto imperiale trasforma individui e collettività in una poltiglia ciberneticamente amministrata, sotto «il sole artificiale dello spettacolo». Abbagliati dal loro errore madornale sull’estinzione dello Stato, e quindi spintisi fino a teorizzare la «fine dell’imperialismo», Hardt e Negri vengono smentiti appena un anno dopo dall’invasione dell’Afghanistan e, di fronte alla seconda guerra all’Iraq che ne segue a stretto giro, non sanno darsi altra spiegazione che la «follia» di Bush II. Di nuovo, Riccardo li confuta in anticipo: «né più credibili possono risultare le interpretazioni di tipo psicologico, che pure qualche commentatore ha proposto, e cioè che Bush soffrirebbe di “delirio di potenza” o di profondo risentimento personale nei confronti del suo servitore fellone [Saddam Hussein, ndr]. La complessificazione della società non lascia spazio a simili semplificazioni». La guerra, al contrario, è il «tragico crocevia» del nostro tempo, «tra i luccichii delle opulenze del consumo e i bagliori delle armi».
Se nel nostro presente queste analisi possono trasmettere una fastidiosa consonanza con un certo sovranismo, l’apparenza non deve ingannare. Che gli Stati Uniti abbiano esercitato fino all’altroieri un’egemonia pressoché assoluta nel capitalismo mondiale, è qualcosa di più e di meno di un giudizio di fatto: è una banalità talmente ovvia che non dovrebbe nemmeno essere ricordata. Più significativo, al contrario, è che tanti compagni e compagne sembrino esserselo dimenticato, mentre altri pezzi di società paiono scoprirlo proprio nel momento del declino dell’assetto imperiale. Chi crede che questa consapevolezza – arrivata in ritardo come la nottola di Minerva – non poggi su altro terreno che la propaganda dello Zar di Russia, fa soltanto del complottismo rovesciato (“politicamente corretto”). Se il mondo, dall’avvento di internet e in particolare delle bolle social, è segnato più che mai anche da «guerre cognitive» per accaparrarsi i cervelli, dietro i movimenti delle coscienze agiscono sempre delle cause materiali. Egemone nel periodo dell’egemonia statunitense (talmente tanto da aver inglobato, “culturalmente” e non solo, anche una parte del proletariato), la classe media declina con il declinare del «secolo americano». Sospesa tra piccoli privilegi sempre più residuali e una crescente proletarizzazione (a livello di salari, consumi, condizioni di vita, modalità di lavoro), e in un quadro di ri-sudditizzazione generale, ha sperimentato fin nei propri corpi tutta la violenza di cui è capace l’Ordine imperiale. Ma se teme quest’ultimo, teme anche i barbari che si affollano alle sue frontiere. Mentre, nella terra dei rapporti sociali, maledice le varie caste (i politici, i banchieri e i loro servi dell’Informazione e della Scienza), invoca dal cielo del Diritto quello stesso Stato che, da «comitato d’affari della borghesia», è ormai divenuto un vero e proprio gabinetto di pianificazione. A questo groviglio di pulsioni, tanto spiegabile quanto intimamente contraddittorio, si rivolgono i pifferai sovranisti, ai quali una certa compagneria – quella che da un po’ di anni ha cominciato a pensare che la NATO ha fatto anche cose buone, o che non bisogna confondersi con le luride plebi populiste – non fa altro che lasciare campo libero. E che musica suonano, i pifferai? In un mondo stravolto da mutamenti radicali che scorrono alla velocità delle immagini, scambiano costantemente la sostanza di quanto sta avvenendo con la sua pura esteriorità. Dal nostro punto di vista, non c’è dubbio che – come avvenuto più volte nella storia – siamo di fronte a un salto di specie della classe dominante, nello specifico dal potere classicamente borghese al potere di una nuova classe, che si può definire tecnocrazia. Al contrario della vulgata liberal-marxista, però, certi trapassi non avvengono mai per semplice rimpiazzo (una classe che ne soppianta un’altra con un colpo di mano). Tra gli Illuministi, che pure partorirono il pensiero borghese, non furono pochi gli aristocratici (pensiamo a un Montesquieu); e ve ne furono anche di più sulle barricate della rivoluzione francese. A Firenze, alcuni dei padroni della città sono tuttora famiglie che risalgono ai tempi di Dante, con tanto di blasoni e titoli. A Carrara, proprietarie delle cave sono a tuttoggi quelle stesse famiglie che se le spartirono nel Settecento. A cambiare, di epoca in epoca, non è tanto chi detiene il potere di classe, ma le condizioni del suo accesso. Definire la tecnocrazia come la classe finanziaria, alla maniera dei sovranisti, dice tutto e non dice nulla: al giorno d’oggi, qualsiasi capitalista di un certo calibro finanziarizza le proprie attività. Al contrario, quella tecnocrazia che sta superando il potere genericamente borghese andrebbe definita come la classe della potenza: quella che si afferma approntando allo Stato i mezzi del suo dominio (prima di tutto le armi, e poi tutto l’armamentario duale delle tecnoscienze, dai cavi in fibra ottica ai mega-datacenter, passando per gli OGM vecchi e nuovi, la biologia di sintesi, i droni, i super-computer quantistici…); e che solo secondariamente, come conseguenza, ha preso e prende sempre di più il controllo dei “mercati”. In questo presente che ama nascondere gli scheletri nell’armadio, i sovranisti hanno almeno il merito di indicarlo, l’armadio. Ma non lo aprono mai. Vi scorgerebbero un mondo degli orrori: schiavi, miniere e fabbriche per approntare quei mezzi di cui nessuno Stato può fare a meno; un mondo-laboratorio popolato da umani cablati per rendere questi mezzi operanti; guerre per accapparrarsi le risorse necessarie a fabbricarli; e, a tutte le latitudini, stuoli di tecnocrati grandi e piccoli pronti a servire i loro Leviatani nella rinegoziazione del mondo. Che le «bande rivali» abbiano imparato bene la lezione dai (sempre più ex-) reggenti imperiali, ce lo dice anche il nome scelto dal Cremlino per l’invasione dell’Ucraina (a sua volta già invasa dai capitali concorrenti e dai loro Servizi): «Operazione Militare Speciale». Quando l’esercito coadiuva o sostituisce la polizia nella normale gestione dell’ordine detto pubblico, mentre è sempre all’opera nel continuo gioco di provocazioni, spesso occultate o proprio invisibili, tra i vari Leviatani, – allora il suo sconfinamento non ne costituisce altro che la variante non-ordinaria e quindi prevista, come prova tecnica di dominio sovra-, o forse ormai meglio meta-, nazionale.
Ciò detto, se oggi la «macchina sovranazionale» di cui ci parla Riccardo sta andando in pezzi (apparentemente in direzione di più blocchi globo-regionali anziché di un ritorno allo Stato-Nazione), le ragioni per attaccarla non sono di meno, ma di più. Messo alle strette dai poli capitalistici emergenti, il capitalismo occidentale è disposto a tutto pur di non mollare la presa, anche a costo di ritrovarsi tra le mani un cumulo di macerie radioattive. Già questa è una buona ragione per combatterlo: perché prenda forma un mondo diverso, deve ancora esserci un mondo. Ma ci sono altre ragioni, e più profonde. I rivoluzionari possono e devono scegliere come giocare (quali fini perseguire, e con che mezzi); ma non possono scegliere il campo da gioco, ovvero l’orizzonte storico in cui agiscono, e al cui interno, oggi, non opera solo la falsa alternativa tra «democrazie» e «regimi autoritari». Piaccia o non piaccia, la nostra è l’epoca in cui, dietro i poli capitalistici emergenti, ci sono masse di dannati della terra che premono per uscire dalla miseria, mentre nelle «aree centrali» milioni di persone scoprono di non vivere nel migliore dei mondi. Senza rinunciare a niente delle nostre prospettive, senza tifare per nessun concorrente, e continuando a ribadire che la sola alternativa reale è il comunismo anarchico (mentre il «multipolarismo» è solo una favola insanguinata), opporci innanzitutto al nostro imperialismo è – come ha scritto qualcuno – la «porta stretta» dalla quale un movimento rivoluzionario non può evitare di passare. Perché è il solo modo per avvicinarci a quei miliardi di esseri umani che sono due volte oppressi e sfruttati: dai loro regimi, che malsopportano, ma spesso accettano come “male minore”, e dalla «macchina sovranazionale» occidentale, dalla quale ora più che mai cercano di liberarsi; perché è il solo modo per ritrovarsi dalla stessa parte della rabbia che monta anche alle nostre latitudini, prima che qualche pifferaio riesca a canalizzarla contro altri oppressi; e perché una trasformazione rivoluzionaria non può né essere concepita né avviarsi senza lo stravolgimento dei rapporti di forza mondiali. Non sappiamo che cosa potrebbe scaturirne, da questo stravolgimento, e se ci concederà un’occasione per «rimettere in discussione, e praticamente, i fondamenti stessi del potere». Possiamo però scommettere che, se questa occasione si darà, sarà l’ultima che l’umanità avrà di fronte prima di sprofondare in quella «lunga stagione buia» su cui Riccardo ci ammoniva più di trent’anni fa.
In questo paesaggio cupo possiamo cogliere almeno un aspetto positivo: se la frantumazione dell’Impero implica il ritorno delle guerre simmetriche, con il loro bisogno massiccio di carne da cannone da arruolare a forza anziché dei soli eserciti professionali, gli appelli alla diserzione smettono di essere mere «esercitazioni retoriche», e la variabile umana può farsi nuovamente sabbia nel motore del militarismo. Se poi l’economia di guerra estende ulteriormente l’arruolamento in senso sociale, raggiungendo luoghi di lavoro e territori, le occasioni per ammutinarsi (scioperando, bloccando, sabotando) si moltiplicano. Mentre i tecnocrati di ognidove corrono al riarmo, tutti gli uomini e le donne di cuore e buona volontà sono a loro volta chiamati ad armarsi: innanzitutto di idee chiare, coraggio e protervia.
Mentre l’aria appare già piuttosto scura, sappiamo che l’alba non verrà da sola.
[novembre 2024]
Categorie
Sul far della sera
Diffondiamo la postafzione all’opuscolo “La guerra come operazione di polizia internazionale” di Riccardo d’Este, curato dal nostro collettivo.